Affrontare il concorso per l’insegnamento della matematica in Italia richiede una preparazione strategica e mirata. Questo percorso, che apre le porte a una carriera nel mondo della scuola, si articola in diverse prove selettive, ciascuna con le proprie specificità. I candidati devono dimostrare non solo una solida padronanza dei contenuti disciplinari, ma anche competenze metodologiche e didattiche all’avanguardia. La capacità di coniugare la tradizione del pensiero matematico con le più recenti innovazioni didattiche è un elemento chiave per il successo.
L’orizzonte della preparazione non può limitarsi al contesto nazionale. Le politiche educative europee e le indagini internazionali sui livelli di apprendimento influenzano i programmi e le metodologie richieste. Comprendere come l’insegnamento della matematica si stia evolvendo nel mercato europeo e nel bacino del Mediterraneo offre una prospettiva più ampia e arricchisce l’approccio didattico del futuro docente. L’obiettivo è formare studenti con competenze solide, capaci di applicare il ragionamento matematico alla risoluzione di problemi complessi, in linea con le esigenze di una società in continua evoluzione.
Le Classi di Concorso per l’Insegnamento della Matematica
Il primo passo per ogni aspirante docente è individuare la corretta classe di concorso in base al proprio titolo di studio. Per l’insegnamento della matematica nelle scuole secondarie, le principali classi di concorso sono la A-26 Matematica, la A-27 Matematica e Fisica e la A-28 Matematica e Scienze. La classe A-26 permette di insegnare in vari indirizzi di licei e istituti tecnici, mentre la A-27, che include anche la fisica, apre le porte anche ai licei artistici e musicali. La classe A-28 è invece specifica per la scuola secondaria di primo grado. È fondamentale verificare i requisiti di accesso, come lauree specifiche e crediti formativi universitari (CFU) in determinati settori scientifico-disciplinari, che sono periodicamente aggiornati dalla normativa ministeriale.
La Struttura delle Prove del Concorso

Il concorso per docenti di matematica, come per le altre discipline, si articola generalmente in una prova scritta e una prova orale, a cui si aggiunge la valutazione dei titoli. La prova scritta, spesso computer-based, è composta da quesiti a risposta multipla volti a verificare le conoscenze disciplinari, le competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Questa fase mira a valutare la padronanza dei contenuti specifici delle classi di concorso, come l’algebra, la geometria, l’analisi matematica e la probabilità.
La prova orale, invece, è un momento cruciale per dimostrare le proprie capacità didattiche. I candidati sono chiamati a simulare una lezione su un argomento estratto a sorte, esplicitando le scelte metodologiche, didattiche e l’uso delle tecnologie. Questa prova non valuta solo il “cosa” insegnare, ma soprattutto il “come”, mettendo in luce la capacità di progettare percorsi di apprendimento efficaci e inclusivi. Per una preparazione completa, è utile consultare il bando del concorso docenti per la secondaria, che definisce nel dettaglio le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione.
La Prova Scritta: Programmi e Tracce Tipo
Il programma d’esame per la prova scritta copre un vasto spettro di argomenti matematici. Per la classe A-26, ad esempio, i temi spaziano dalla logica matematica alla geometria euclidea e cartesiana, dall’algebra lineare al calcolo differenziale e integrale. Vengono richieste anche conoscenze di probabilità, statistica e storia della matematica. Le tracce dei concorsi passati mostrano quesiti che richiedono non solo la conoscenza delle definizioni e dei teoremi, ma anche la capacità di applicarli per risolvere problemi complessi, come la massimizzazione dell’area di figure geometriche o l’analisi di funzioni. È essenziale, quindi, affiancare allo studio teorico una costante esercitazione pratica su quiz e tracce svolte.
Per le classi di concorso che includono altre discipline, come la A-27 (Matematica e Fisica) e la A-28 (Matematica e Scienze), il programma si amplia ulteriormente. I candidati devono dimostrare competenze anche in ambiti come la meccanica, la termodinamica, l’elettromagnetismo per la fisica, oppure la biologia, la chimica e le scienze della Terra per le scienze. La preparazione deve essere necessariamente interdisciplinare, mostrando di saper cogliere i collegamenti tra i diversi saperi. Risorse come i manuali specifici e i simulatori online sono strumenti preziosi per familiarizzare con la tipologia di quesiti e per ripassare in modo mirato tutti gli argomenti previsti dal bando.
La Prova Orale: Progettare un’Unità di Apprendimento (UDA)
La prova orale è incentrata sulla progettazione di un’attività didattica, spesso sotto forma di Unità di Apprendimento (UDA). L’UDA è un percorso che coinvolge gli studenti in modo attivo e li porta a realizzare un prodotto finale, sviluppando competenze trasversali. Durante la lezione simulata, il candidato deve illustrare tutte le fasi della sua progettazione: dai prerequisiti agli obiettivi di apprendimento, dalle metodologie didattiche scelte (come il cooperative learning o il problem solving) agli strumenti di valutazione. È fondamentale dimostrare di saper creare un ambiente di apprendimento inclusivo, che tenga conto dei diversi stili cognitivi e dei Bisogni Educativi Speciali (BES), come spiegato nella guida alla didattica inclusiva per DSA e BES.
Un esempio pratico potrebbe essere un’UDA sulla similitudine tra triangoli. Si potrebbe partire da un problema reale, come calcolare l’altezza di un edificio usando la sua ombra, per poi guidare gli studenti, attraverso attività di laboratorio e l’uso di software di geometria dinamica, alla scoperta delle proprietà dei triangoli simili. La valutazione non si limiterebbe alla classica verifica scritta, ma potrebbe includere l’osservazione del lavoro di gruppo e l’autovalutazione da parte degli studenti. Questo approccio, che unisce teoria e pratica, tradizione e innovazione, è molto apprezzato dalle commissioni d’esame.
Risorse e Strategie per la Preparazione
Una preparazione efficace richiede una combinazione di studio teorico, esercitazioni pratiche e aggiornamento costante. Esistono numerosi manuali specifici per le diverse classi di concorso, che offrono una trattazione completa degli argomenti d’esame e raccolte di tracce svolte. Molte case editrici mettono a disposizione anche piattaforme online con simulatori di test, utili per allenarsi in condizioni simili a quelle della prova scritta. È inoltre consigliabile consultare i siti istituzionali, come quello del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), per reperire la normativa di riferimento, i programmi ufficiali e i quadri di valutazione.
Oltre ai libri di testo, è importante approfondire le competenze metodologico-didattiche. La conoscenza dei principali modelli di apprendimento e delle strategie didattiche innovative è essenziale per la prova orale. Partecipare a corsi di formazione, webinar e confrontarsi con altri candidati può essere un ottimo modo per arricchire la propria preparazione. Infine, non bisogna sottovalutare l’importanza di acquisire titoli e certificazioni che possono aumentare il punteggio in graduatoria, come master, corsi di perfezionamento e certificazioni informatiche o linguistiche.
In Breve (TL;DR)
Questa guida completa analizza le prove del concorso per l’insegnamento della matematica, fornendo dettagli su programmi, tracce d’esame e risorse strategiche per superare la selezione.
Analizziamo i programmi ministeriali, forniamo esempi di tracce e offriamo consigli pratici per affrontare con successo ogni fase della selezione.
Approfondiremo inoltre le strategie più efficaci e le risorse indispensabili, come checklist e modelli scaricabili, per massimizzare il punteggio e superare ogni fase della selezione.
Conclusioni

Il concorso per l’insegnamento della matematica è un traguardo impegnativo ma raggiungibile con un piano di studi ben strutturato e una preparazione mirata. La chiave del successo risiede in un approccio integrato che bilanci la solida conoscenza della disciplina con le più moderne competenze didattiche. È necessario andare oltre la semplice memorizzazione di formule e teoremi, per abbracciare una visione della matematica come strumento vivo per interpretare la realtà, in linea con le indicazioni nazionali ed europee. La capacità di progettare lezioni stimolanti, inclusive e tecnologicamente avanzate farà la differenza non solo in sede di esame, ma soprattutto nell’aula di tutti i giorni, formando le nuove generazioni di cittadini consapevoli e competenti. La passione per la materia, unita a una professionalità costantemente aggiornata, rimane l’ingrediente fondamentale per diventare un insegnante efficace e apprezzato.
Domande frequenti

Le principali classi di concorso per l’insegnamento della matematica nelle scuole secondarie italiane sono la A-26 (Matematica), la A-27 (Matematica e Fisica) e la A-28 (Matematica e Scienze). La A-26 è specifica per la matematica nei licei e istituti tecnici. La A-27, invece, abilita all’insegnamento congiunto di matematica e fisica, tipicamente nei licei scientifici. Infine, la A-28 è destinata all’insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado (scuole medie).
La prova orale ha una durata massima di 45 minuti e si compone di due parti principali. La prima è una lezione simulata su un argomento estratto dal candidato 24 ore prima della prova. La seconda parte consiste in un colloquio disciplinare che valuta la padronanza degli argomenti del programma, le competenze didattiche, la capacità di progettazione e l’uso delle tecnologie. È inoltre prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese a livello B2.
Il programma d’esame è vasto e copre diverse aree della matematica. Gli argomenti chiave includono l’algebra (polinomi, equazioni), la geometria euclidea e analitica (coniche, rette, piani), l’analisi matematica (funzioni, limiti, derivate, integrali, equazioni differenziali), la probabilità e la statistica. È anche importante approfondire la didattica della matematica e la capacità di creare modelli matematici per risolvere problemi reali, come richiesto dalle tracce dei concorsi precedenti.
Il punteggio finale non dipende solo dall’esito delle prove d’esame, ma anche dalla valutazione dei titoli culturali e di servizio. Per incrementare questo punteggio, è possibile conseguire master universitari di I o II livello, corsi di perfezionamento, certificazioni informatiche (come LIM o coding) e certificazioni linguistiche (in particolare di livello C1 o C2). Anche il servizio accumulato tramite supplenze contribuisce in modo significativo al punteggio totale.
Sì, ci sono differenze sostanziali. Per la classe A-26 (Matematica) è richiesta una laurea magistrale in discipline come Matematica, Fisica, Informatica o Ingegneria, con un numero specifico di Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori matematici. Per la classe A-27 (Matematica e Fisica), i requisiti sono più stringenti e richiedono, oltre a una solida base matematica, anche un numero consistente di CFU in settori scientifico-disciplinari della Fisica, data la natura congiunta dell’insegnamento.







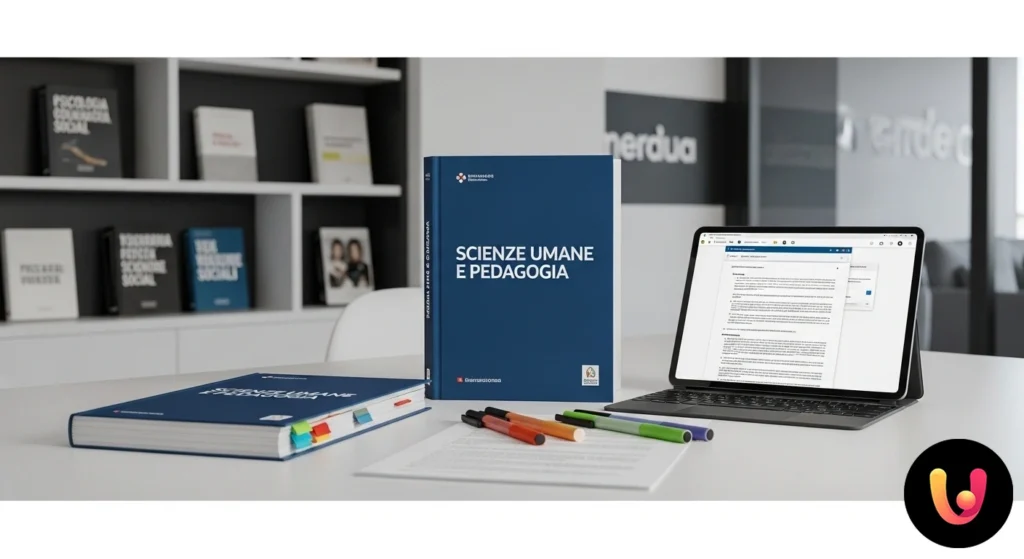
Hai trovato utile questo articolo? C’è un altro argomento che vorresti vedermi affrontare?
Scrivilo nei commenti qui sotto! Prendo ispirazione direttamente dai vostri suggerimenti.